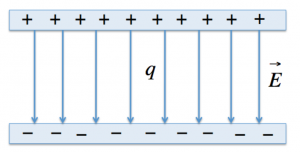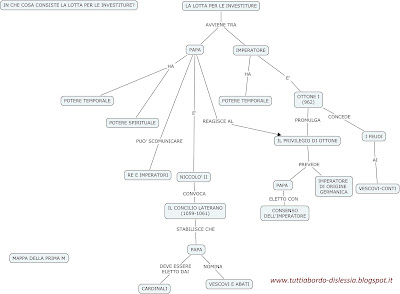Il declino dell’Ancien Régime
L’attuale architettura economica internazionale si originò all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti emergevano come leader indiscussi del Nord capitalista e le politiche estere statunitensi del dopoguerra venivano elaborate con l’obiettivo condiviso di preservare l’economia globale dopo la sanguinosa transizione di potere. Con il 50% del PIL mondiale, gli Stati Uniti prevalsero sui centri industriali restanti, crearono nuove istituzioni ed elargirono una tale quantità di capitale e aiuti che permisero alle economie dell’Europa Occidentale e del Giappone di resuscitare.
Le istituzioni di Bretton Woods – il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca Mondiale) – le agenzie delle Nazioni Unite e l’Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e il Commercio (GATT) videro la luce in questo contesto geopolitico per assicurare la transizione verso un funzionamento lineare di interdipendenza nell’area OCSE. Furono proprio gli Stati Uniti, in quanto leader e gestori della “comunità di sicurezza”, a promuovere e assicurare questa interdipendenza economica e di sicurezza.
La fine della Guerra Fredda accelerò il processo di globalizzazione economica. La divisione del lavoro dell’area OCSE fu poi estesa alle economie della periferia. Questa interdipendenza fu promossa unicamente per i vantaggi senza precedenti tratti dal Nord – infrastrutture industriali high-tech, una forte base di ricerca e sviluppo, società multinazionali ben fondate, marchi potenti e una catena del valore di consumo domestico. Ciò di cui c’era bisogno era accesso al lavoro e a industrie di produzione per mantenere attivo il centro industrializzato. Tutto questo era presente in abbondanza nelle economie emergenti. È utile sottolineare gli effetti empirici di questa interdipendenza: nel 1996, le principali economie industriali presentavano un attivo complessivo di 42 miliardi di dollari, paragonato al passivo totale di 90 miliardi di dollari del Sud. Nel 2004, la situazione geopolitica era ormai già cambiata. Le economie industriali presentavano un passivo totale di 400 miliardi di dollari (un passivo estero di 666 miliardi per i soli Stati Uniti), contro le economie emergenti che presentavano un attivo di 327 miliardi di dollari. Il cambiamento fondamentale fu che il Nord stava indirizzando alcune produzioni di segmento inferiore verso il Sud emergente e questo ebbe un impatto sulla bilancia commerciale.
Per molti aspetti, non solo la globalizzazione è andata di gran lunga oltre le istituzioni che avrebbero dovuto regolarla, ma si è anche diffusa al di là della gerarchia guidata dagli Stati Uniti, e cioè delle nazioni che non sono state associate o integrate nel sistema di sicurezza occidentale. Questo fenomeno è stato ben catturato dalla brillante battuta di Thomas Friedman nel 1999: «La verità più semplice sulla globalizzazione è la seguente: nessuno è responsabile». Ad esempio, in una fase precedente di squilibri globali nei primi anni ’80, gli Stati Uniti furono in grado di assemblare il G5 e attuare l’Accordo del Plaza nel 1985 per creare un riadattamento in termini di scambi commerciali tra gli Stati Uniti e le altre tre grandi economie dell’epoca – Germania Occidentale, Regno Unito e Giappone – e obbligare quest’ultimo a sopportare il peso del riadattamento globale. Tra il 1985 e il 1987, il dollaro fu deprezzato del 51% nei confronti dello yen giapponese e questo permise agli Stati Uniti di ridurre rapidamente il disavanzo di bilancio. Nell’attuale contesto di globalizzazione questo non è più possibile. Oggi ci sono delle nazioni che sono diventate attori importanti nella divisione globale del lavoro senza far parte della comunità di sicurezza dell’Occidente o del Nord. Ne consegue che la Cina, ad esempio, non può essere costretta o persuasa, allo stesso modo o con gli stessi mezzi impiegati nei confronti del Giappone venti anni fa, a sopportare il peso del riadattamento globale.
Le istituzioni di Bretton Woods inoltre sono state create in un momento in cui lo Stato era attore fondamentale nell’economia mondiale. Il modello capitalistico keynesiano da Guerra Fredda, che si basava su un patto tra grande capitale, grande lavoro, grande governo, ha ceduto il passo negli anni ’70 e ’80 un’ondata di deregolamentazioni e privatizzazioni che hanno trasferito le capacità industriali in oligopoli privati e multinazionali. Oggi le multinazionali detengono più di due terzi delle esportazioni mondiali di beni e servizi, di cui una parte rilevante è costituita da scambi intraziendali. Si stima che il 35% degli scambi globali sia rappresentato proprio da questo tipo di commercio.
Le istituzioni per la governance globale non sono state al passo con tali sviluppi. Ad esempio, non ci sono dati affidabili pubblicati regolarmente riguardo le catene di approvvigionamento delle multinazionali per conoscere la vera portata dell’“interdipendenza”. Tutto questo è sorprendente perché esistono dati esaustivi che analizzano le economie nazionali e il livello di interazione tra gli Stati, mentre non si può dire altrettanto per quanto riguarda gli oligopoli che dominano le leve fondamentali dell’economia globale. Le istituzioni sono dunque rimaste indietro e non sono in grado di monitorare o regolare l’evoluzione geo-economica.
Un’altra caratteristica fondamentale della crisi attuale è stata l’incapacità dei nuclei familiari nordamericani ed europei di pagare il consumo di beni prodotti a basso costo nelle zone dell’Asia Pacifica. Negli Stati Uniti, sia lo Stato sia i privati hanno vissuto oltre le proprie possibilità; nella maggior parte dell’Eurozona, lo Stato ha accumulato molto debito, considerati anche gli obblighi sociali relativamente più alti. Il rapporto debito-PIL medio per le economie avanzate è del 95%; per le economie emergenti è del 35%.
La globalizzazione commerciale e finanziaria, quindi, si è rivelata intrinsecamente legata ai flussi di capitale negli Stati Uniti supplendo così alle proprie mancanze strutturali di scambio. Pur essendo i maggiori debitori del mondo, gli Stati Uniti stessi forniscono la principale riserva di valuta – il dollaro americano – ai propri creditori trasferendo così la vulnerabilità dello squilibrio su questi ultimi. Una delle principali cause della crisi attuale è l’abuso sistematico dello status di valuta di riserva da parte degli Stati Uniti e i costi asimmetrici imposti al resto del mondo. L’illimitata espansione monetaria, grazie alla stampa di dollari da parte della Federal Reserve, ha imposto agli altri paesi attori nella finanza internazionale due strategie politiche tra cui scegliere. La prima: lasciare che il valore delle proprie valute aumenti nei confronti del dollaro, il che implica una diminuzione di domanda aggregata (esportazioni) e un aumento della disoccupazione. La seconda: promuovere un’espansione monetaria (stampare più valuta interna) per adattarsi alla svalutazione del dollaro, il che si manifesta poi in inflazione di beni e cespiti. Sostanzialmente, la scelta è tra una rivalutazione del tasso di cambio nominale e una di quello reale. L’espansione monetaria statunitense ha creato anche bolle di cespiti e volatilità nei mercati emergenti in molti settori come quello del petrolio, del mercato immobiliare, delle materie prime e dell’oro; perciò gli investitori hanno deviato la liquidità in eccedenza in assets di maggior rendimento che contribuiscono molto poco ad alimentare la capacità dell’economia reale.
L’asimmetria di questo “privilegio esorbitante” ha raggiunto un livello in cui l’intera base di scambio di ricchezza reale (esportazioni di merce negli Stati Uniti) e contanti (accumulo di debito statunitense) viene messa in discussione. L’utilizzo crescente di valuta regionale per gli scambi e gli investimenti è una risposta razionale delle economie emergenti che sono più esposte alla svalutazione ineluttabile del dollaro americano. È anche in questo contesto che nella Dichiarazione di Delhi dei paesi BRICS del 28 marzo 2012 si richiama a un «sistema monetario internazionale giusto che possa servire gli interessi di tutti i paesi e sostenere lo sviluppo di economie emergenti e in via di sviluppo».
La legittimità della leadership statunitense è stata sostenuta dal proprio ruolo di garante della stabilità mondiale e dalla propria abilità nel fornire benefici asimmetrici ai nuovi membri dell’economia globale attraverso l’accesso ai mercati, al capitale e alla tecnologia. È stata l’abilità degli Stati Uniti a promuovere investimenti e commercio con la promessa di un’economia mondiale reciprocamente benefica. Al contrario, negli ultimi decenni la posizione statunitense nell’economia globale è diventata quella di un “free rider” in cui regioni industriali cruciali come l’Europa e il Giappone e le economie in via di sviluppo e dei BRICS vengono obbligate a sottoscrivere la dissolutezza nordamericana sopportandone i costi nazionali a medio o a breve termine. Il fatto che gli Stati Uniti non possano mantenere la missione originaria di fornitori di beni pubblici è testimonianza del fatto che gli accordi post-1945 devono essere adattati e modificati per riflettere la realtà attuale.
Come ha osservato l’economista politico Giovanni Arrighi, «il collasso di un qualsiasi ordine egemonico è dovuto al fatto che l’aumento del volume e delle dinamiche del sistema supera le capacità organizzative dello specifico complesso egemonico che ha creato le condizioni dell’espansione sistematica». In altre parole, l’attuale ciclo di globalizzazione economica ha gettato le basi della propria crisi.
E dopo l’egemonia?
Il discorso dominante sostiene che con la scomparsa del “momento unipolare”, al declino relativo dell’Occidente seguirà un “caos multipolare” che si disferà della stabilità economica e geopolitica che il predominio nordamericano ha garantito al sistema internazionale. Infatti, la teoria della stabilità egemonica, derivata dal discorso dominante, afferma che la stabilità del sistema richiede un unico egemone per articolare e far rispettare le regole di interazione tra gli attori principali.
Il quesito che si pone è se si tratti di una narrativa egocentrica, generata da un Occidente riluttante e incapace di analizzare il corso della storia che potrebbe non conformarsi più ai 500 anni di capitalismo occidentale e alla preminenza geopolitica dell’Occidente-garante.
A dire il vero, gli ultimi secoli di predominio occidentale hanno visto cicli di transizione del potere, dove egemoni venivano sostituiti da altre potenze emergenti, generalmente dopo un periodo di lotte e conflitti intensi. Ogni successiva transizione di potere egemonico implicava un’espansione dell’economia globale sia in termini di complessità che di portata geografica con un nuovo Stato dominante che sottoscriveva l’interdipendenza dell’epoca. Come ha affermato Arrighi, ogni nuovo ordine egemonico era «dotato di migliori capacità sistemiche rispetto al precedente complesso egemonico» per ripristinare il processo di globalizzazione economica dopo un periodo di tumulti.
Perciò, visto lo sviluppo storico del capitalismo globale, non sorprende che le analisi più diffuse anticipino l’emergere di un altro egemone per ripristinare la “lunga durata” del capitalismo. Tuttavia queste predizioni sono erronee. L’attuale transizione dalla pax americana a un nuovo regime di governance mondiale non può replicare il modello storico di una transizione violenta di potere che apre la strada a uno Stato o blocco egemonico più capace. Il ragionamento è il seguente.
Innanzitutto, assistiamo a una biforcazione del sistema internazionale, dove le migliori capacità militari rimangono nel blocco guidato dagli Stati Uniti mentre i centri economici più dinamici per l’accumulazione di capitale stanno emergendo al di fuori di questa gerarchia, non più guidati dagli Stati Uniti ma dalle economie dei BRICS. Ciò rappresenta una rottura storica rispetto a tutti i precedenti cicli dove le potenze ascendenti non solo mostravano maggiore dinamismo delle potenze in carica, ma sviluppavano contestualmente una forza militare e geopolitica adatta a quella vitalità economica. Secondo le tendenze attuali, le potenze emergenti non sarebbero in grado di dominare militarmente il Nord guidato dagli Stati Uniti anche dopo lo scioglimento dell’unipolarità.
Una soluzione per risolvere questa biforcazione del sistema internazionale è stata la proposta ingegnosa di alcuni studiosi occidentali di istituire un “G-2”: una grande coalizione tra gli Stati Uniti e la Cina in grado di controllare l’attuale fase di globalizzazione e lo status quo geopolitico. Nei primi mesi dell’amministrazione Obama ci si è soffermati su questa idea ma poi si sono subito evidenziate contraddizioni geopolitiche e geo-economiche impossibili da superare. La Cina, dal canto suo, probabilmente ha riconosciuto che le concessioni geopolitiche da parte dell’Occidente, che avrebbero potuto indurla a formare questo compatto globale, sarebbero state poco convenienti per l’Occidente stesso, rendendo l’intero progetto così inverosimile da non meritare neanche un dibattito. In ogni caso, l’identità statale della Cina, che ha sempre fatto affidamento su una narrativa anti-egemonica, costringerebbe anche la leadership più cooperativa a Pechino a non trasformare il ruolo internazionale della Cina in esplicito collaboratore dell’Occidente.
Il secondo motivo per cui la tendenza storica della transizione del potere egemonico non può essere replicata è perché l’ambiente militare e tecnologico esclude una lotta di potere violenta. La caratteristica identificativa dell’era nucleare è che la guerra rivoluzionaria è diventata impossibile. Di conseguenza, l’emergere di potenze regionali avrà minori possibilità di far leva sulle crescenti capacità di destituire le grandi potenze esistenti con minacce di forza. Naturalmente, la logica della deterrenza strategica funziona per entrambi i versi. L’egemone in declino ugualmente non può far leva sulla superiorità convenzionale per riordinare e salvare l’attuale sistema attraverso la conquista o la coercizione. Questa è la chiara lezione del decennio scorso.
L’idea che i BRICS possano emergere come un blocco geopolitico che si sostituisca al blocco in declino guidato dagli Stati Uniti è perciò una previsione errata. Al contrario, ciò per cui bisogna essere pronti è un sistema globale frammentato e decentralizzato che non può essere salvato da un nuovo blocco egemonico. Un concetto democratizzato di ordine mondiale è quindi l’unica alternativa fattibile a un lungo periodo di tumulti e adattamento caotico da parte degli Stati più importanti. Come ha affermato l’economista politico Robert Cox, «il nuovo ordine dovrà essere costruito dal basso nel momento in cui l’attuale ordine vacillerà nel tentativo di mantenere tutto in piedi dall’alto».
L’equilibrio di potere emergente non produrrà necessariamente una competizione incontrollata e un “mondo a somma zero” se i poli emergenti sceglieranno di concentrarsi sui problemi a livello di sistema come la sicurezza dei popoli, la riorganizzazione e la regolamentazione della finanza mondiale in modo da renderla meno destabilizzante e più volta allo sviluppo, il potenziamento delle istituzioni per la sicurezza comune come l’ONU e le altre istituzioni regionali nascenti. Con la diminuzione del predominio statunitense, il “problema dell’azzardo morale” che conduce alla sregolatezza sarebbe sostituito da nuovi incentivi che costringerebbero le potenze emergenti a farsi carico in maniera più responsabile delle proprie regioni, specialmente per l’approvvigionamento di beni pubblici.
Ironicamente, ciò che l’unipolarità non è riuscita ad attuare – riallineare le politiche nazionali con i problemi a livello di sistema – potrebbe essere realizzato in un mondo in cui il potere, e quindi la responsabilità, sia distribuito. La principale sfida sarà superare la faziosità epistemica nel discorso dominante che impedisce di visualizzare un regime di governance globale multilaterale e democratizzato che non richieda una gerarchia egemonica per regolarsi e sostenersi.
E dopo la globalizzazione?
Alcuni vedono i BRICS come un’occasione per resuscitare il modello attuale di globalizzazione con poche riforme tattiche. Il problema principale è che l’attuale offerta implicita alle economie emergenti è insincera: condividere un peso crescente per riequilibrare e stabilizzare il Sud emergente. Perciò, la riforma globale deve cominciare con riadattamenti da parte del Nord che ancora trae vantaggi in maniera sproporzionata dalla globalizzazione.
Tuttavia, è importante discutere se i BRICS, assumendo che ne abbiano la capacità, dovrebbero ripristinare la globalizzazione primordiale. Alcuni economisti sembrano sostenere i BRICS partendo dal presupposto che queste economie saranno d’aiuto nel rinvigorire il processo di globalizzazione. Secondo questa tesi, visto che i membri dei BRICS hanno beneficiato della prospera fase di globalizzazione, ora in difficoltà, è loro interesse sostenere il sistema che altrimenti potrebbe minare la loro crescita. Infatti, fin dal 2001, i Brics hanno rappresentato più del 30% della crescita economica globale.
A prima analisi, questo ragionamento sembra convincente. Tuttavia, se si adotta una analisi distaccata e lungimirante su costi e benefici della struttura di crescita che le economie emergenti hanno adottato, come analizzare le conseguenze della disuguaglianza sociale, lo sviluppo del capitale umano, la degradazione ecologica, l’innovazione locale e l’instabilità finanziaria, si arriverà alla conclusione che anche i BRICS hanno un lato vulnerabile che riflette la loro partecipazione attiva nel modello mondiale di neoliberismo iniquo e squilibrato. In realtà, alcuni membri dei BRICS rimangono indietro anche rispetto a economie del Sud a basso reddito per quanto riguarda il capitale umano pro capite e gli indicatori socio-economici, sebbene le statistiche suggeriscano un successo nazionale.
Parti delle élite politiche dei BRICS hanno riconosciuto queste contraddizioni malgrado non ci sia ancora pieno consenso sulla lezione della crisi economica mondiale, e cioè che riprodurre il capitalismo occidentale risulta essere disastroso a livello sia nazionale sia mondiale. I vincoli delle risorse sono tali che i BRICS, che rappresentano il 43% della popolazione mondiale, non possono assumere i livelli di consumo pro capite di energia non rinnovabile e di altre risorse naturali del Nord senza minare seriamente la stabilità ecologica globale e nazionale. In altre parole, i BRICS non possono emulare “l’impronta ecologica” del Nord nelle future strategie di sviluppo.
Inoltre, l’attuale spettro di soluzioni tecnologiche disponibili per superare le carenze malthusiane richiede esso stesso una notevole quantità di risorse e combustibile fossile per le proprie applicazioni, quindi impone una richiesta ancora più intensa sulle limitate risorse disponibili. In questo contesto l’attuale agenda per il cambiamento climatico risulta inadatta in quanto cerca semplicemente di limitare il potenziale di crescita del Sud senza alterare fondamentalmente il modello di industrializzazione attuale dipendente dai combustibili fossili o senza modificare la struttura di accumulazione del capitale. Logicamente, è necessario prevedere tutto un nuovo spettro di soluzioni tecnologiche per sostenere la crescita in un mondo limitato dalle risorse. Inutile dire che questo può essere solo uno sforzo collaborativo la cui intenzione è riconosciuta nella Dichiarazione di Delhi che richiede «flusso di conoscenza tra gli istituti di ricerca» nelle «aree prioritarie quali l’alimentazione, i medicinali, la salute e l’energia» e «nel campo delle nanotecnologie, biotecnologie, scienze dei materiali».
Risulta esserci chiaramente la necessità di costruire un nuovo discorso che incoraggi l’accumulazione regolamentata di capitale e che accordi simultaneamente uguale priorità alla sostenibilità e allo sviluppo del capitale umano. Alcuni economisti politici ritengono che la portata della crescita esperita negli ultimi decenni sarebbe stata impossibile da raggiungere senza distruggere l’ecosistema e degradare (sottoquotare) il valore del lavoro e dell’iniziativa umana con una sproporzione dei costi sostenuti dalle economie del Sud. Se ciò è vero, i BRICS allora hanno un interesse strategico nello sviluppare un discorso che disincentivi questa accumulazione di capitale sfrenata e che sostituisca l’uniformità intellettuale della struttura di globalizzazione attuale grazie alla diversità di politiche, “spazio politico”, e a esperimenti, con soluzioni decentralizzate e dal basso in armonia con le realtà locali.
I BRICS artefici del proprio cambiamento
Affinché i BRICS possano essere agenti di cambiamento, risolvendo i propri squilibri interni, devono stabilire delle priorità di politiche. L’impatto della crisi mondiale ha reso tutto ciò inevitabile.
Come anticipato, la globalizzazione ha coinvolto la produzione industriale di fascia media e ad alta intensità di lavoro, e la gestione di servizi, precedentemente situati unicamente al Nord, che vengono delocalizzati e subappaltati alle economie emergenti. In Asia, questa frammentazione ha creato ciò che gli economisti chiamano “sotto-assorbimento” in cui la produzione eccede i consumi mentre in Occidente i consumi eccedono le entrate generando così “sovra-assorbimento”. Le eccedenze nel primo caso e i disavanzi nel secondo sono espressione empirica di questa divisione globale del lavoro.
La crisi economica globale ha incrinato questa situazione per due ragioni. La prima: deindustrializzazione e conseguenti effetti avversi della disoccupazione nel Nord hanno reso la delocalizzazione a più lungo raggio politicamente difficile. In secondo luogo, l’accumulo massiccio di debito sovrano e familiare nel Nord implica l’incapacità di assorbire a pieno la produzione manifatturiera orientata all’esportazione che le multinazionali hanno stabilito nel Sud emergente.
La domanda che ne deriva è cosa succederà alle infrastrutture di produzione del Sud, incluse quelle dei BRICS, la cui raison d’être è stata quella di approvvigionare il Nord.
Le economie emergenti dovranno limitare le spese e dirottare i loro sistemi di produzione e scambio verso la domanda interna e regionale. Una delle conseguenze dello sviluppo di una struttura orientata all’esportazione è che i risparmi interni aumentano invariabilmente per finanziare la produzione e le relative infrastrutture, i salari vengono ridotti per rendere la forza lavoro attraente al capitale internazionale e i consumi calano naturalmente. La Cina esemplifica questo modello. Ad esempio, l’attuale percentuale del PIL della Cina relativa alle famiglie, cioè salari e consumi, è del 35% rispetto al picco del 56% nel 1983. Nel 2010, il salario dei lavoratori cinesi equivaleva al 25% del PIL, contro la media mondiale del 55%. Un aumento dei salari, e quindi delle entrate, è un passo fondamentale per dare nuovo slancio ai consumi interni.
A livello filosofico, i BRICS dovrebbero ridefinire la metrica del progresso economico e rimettere in discussione il concetto di sviluppo.
Prima di tutto, una delle considerazioni ancora persistenti dell’interdipendenza Nord-Sud è che, con l’ingresso delle economie emergenti nella globalizzazione, l’accumulazione di capitale è diventata più facile rispetto all’“accumulazione del capitale intellettuale”, quest’ultimo mantenuto strategicamente dalle multinazionali del Nord. Per superare ciò, le élite dei BRICS dovrebbero porre fine all’ossessione del tasso di crescita del PIL, e concentrarsi maggiormente sulla metrica che misura effettivamente le realtà sociali, il capitale umano, l’innovazione e il potenziale tecnologico delle proprie economie. In molte economie dei BRICS infatti, e in tutto il Sud del mondo in generale, si osserva che malgrado l’alto tasso di crescita del PIL c’è stato un progresso minimo degli indicatori di sviluppo umano, sicurezza alimentare e nutrizione, scienza e tecnologia, e sistemi sanitari e dell’istruzione. Inoltre, se le economie dei BRICS mirano a migliorare i termini di scambio con il Nord, innalzando cioè la catena dei valori con l’aumento del valore aggiunto in loco, lo sviluppo che mette al centro le persone come definito in precedenza potrà sostenere l’ascesa del Sud emergente.
In secondo luogo, i BRICS in quanto istituzione possono promuovere una dialettica per cui la logica dell’accumulo illimitato di profitto, intrinseco al capitalismo, è controbilanciato da uno Stato dinamico, reattivo e strategico. Quest’ultima questione è importante perché c’è un disprezzo implicito, se non aperto, dello Stato in alcune economie dei BRICS. Ad esempio, la nascita di una ideologia anti-statale in India sta ironicamente anche minando le prospettive dei grandi capitali che si trovano ora a scoprire che la mancanza dello Stato nella vita socio-economica riduce le prospettive a lungo termine di accumulazione di capitale! Come mostra la storia del mondo sviluppato, la dicotomia “Stato vs mercato” è un’invenzione contemporanea ed erronea emersa dal rifiuto dello statalismo da parte di Reagan e della Thatcher. Storicamente, entrambi gli elementi sono indispensabili per il funzionamento del capitalismo. Senza uno Stato robusto, non ci può essere una governance, nessuna agenzia che possa stabilire e far rispettare i diritti di proprietà, e nessuno che assicuri lo sviluppo e il flusso sistematico di prodotti, lavoro e capitali. Infatti, come ritengono alcuni storici tra cui Immanuel Wallerstein, lo stato vestfaliano è stato il lascito più duraturo del capitalismo europeo.
In terzo luogo, indubbiamente l’interdipendenza tra i capitali del Nord e il lavoro dei BRICS ne ha influenzato negativamente i lavoratori. Questi ultimi non possono essere biasimati per essersi domandati perché i loro risparmi duramente guadagnati non siano stati reinvestiti in capitale produttivo interno o in infrastrutture sociali ma “riciclati” nuovamente nel debito occidentale per finanziare i consumi occidentali con la mediazione dello Stato. È necessaria una ricostruzione ideologica del capitalismo e un nuovo patto tra il capitale e il lavoro, analogo al “New Deal” degli anni Trenta, come risposta alla crisi della “sovraccumulazione”. La differenza sta nel fatto che l’attuale crisi richiede che tale accordo sia su scala globale. Lo Stato assumerà inevitabilmente un ruolo centrale nel regolarlo e sostenerlo. Non sorprende che l’economia politica del Nord rifiuti questo “New Deal” e che le caratteristiche ridistributive conseguenti siano disastrose non solo ideologicamente ma anche materialmente perché significherebbero cedere ricchezza, e quindi potere, al Sud emergente.
I BRICS, tuttavia, non possono riequilibrare le proprie economie senza forgiare un accordo tra capitale e lavoro; il fatto che forniscano le risorse sia spaziali sia umane essenziali per la produzione globale rappresenta potenzialmente una leva contrattuale che i BRICS possono usare collettivamente.
In ogni caso, per ora il Nord riesce a sfruttare facilmente l’intensità di competizione tra le economie dei BRICS e questo rende impossibile attuare uno spirito di collettivismo.
La minaccia nei BRICS
Dal 2001, gli scambi commerciali tra i BRICS sono cresciuti a una media del 28% l’anno e sono aumentati di quindici volte raggiungendo i 230 miliardi di dollari nel 2011. Questa cifra rappresenta solo il 10% degli scambi totali dei BRICS, e suggerisce che il commercio tra loro sia ancora modesto rispetto agli scambi con il Nord. Al vertice di Delhi del 28 marzo 2012, i ministri dei BRICS si sono prefissati di aumentare gli scambi nella regione di 500 miliardi di dollari entro il 2015.
Larga parte del commercio tra i BRICS, finora, è stata incentivata dalla domanda finale del G3: USA, UE e Giappone. Quindi, l’interdipendenza tra i BRICS è stata guidata in parte dall’interdipendenza tra i BRICS e le economie del Nord. Ora, con questi ampi mercati ad alto reddito in pericolo, un’economia globale debole conduce a politiche deleterie. Inoltre, la concorrenza tra i BRICS per una quota di mercato e per le risorse naturali presenta un rischio reale che potrebbe diventare l’antitesi del collettivismo dei BRICS.
Dati empirici sembrano confermare questa tendenza. In un recente studio, Simon Evenett, dell’università di San Gallo in Svizzera, ha scoperto che, tra novembre 2008 e luglio 2011, la Russia ha intrapreso 138 misure protezionistiche contro le altre nazioni BRIC, l’India ne ha adottate 85, il Brasile 52 e la Cina 33.
Questa contraddizione, comunque, non può essere ignorata: altrimenti le economie dei BRICS continueranno a fare affidamento sulle esportazioni per prevenire l’instabilità sociale e generare disavanzi per altri obiettivi di sviluppo. Sarà probabilmente possibile gestire questa competizione in modo da non minare né il potenziale per il collettivismo dei BRICS, né la stessa interdipendenza economica tra questi paesi.
Infatti, se gli Stati Uniti, l’Europa e il Giappone possono competere in maniera vigorosa tra le proprie multinazionali senza compromettere l’agenda strategica comune per preservare i vantaggi asimmetrici in termini globali di scambio, perché i BRICS non possono riconciliare la logica della concorrenza con il collettivismo parallelo di importanza strategica per ripensare le regole dell’economia globale a favore del Sud?
Il vertice di Delhi del 2012 ha tentato di trovare misure pratiche per stimolare gli scambi e gli investimenti tra i BRICS. Secondo un memorandum di intesa, questi Stati hanno convenuto su un patto per estendere il credito transnazionale in valuta locale delle proprie economie. Ugualmente interessante è la prospettiva di una «banca di sviluppo per mobilitare le risorse per infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile nei BRICS» e altre economie in via di sviluppo. La dichiarazione di Delhi ha portato i ministri delle finanze a esaminare la fattibilità di questa iniziativa.
Tuttavia, le dinamiche tra i BRICS includeranno sempre elementi di concorrenza e cooperazione. Se gli squilibri bilaterali nei BRICS non saranno affrontati seriamente, non ci saranno prospettive reali per il potenziamento del protezionismo ancora nascente bensì l’esclusione dei membri dei BRICS dai pochi centri di crescita rimanenti.
Conclusioni
Il persistente flusso nell’economia politica internazionale suggerisce una crisi sia ideologica sia geopolitica e geo-economica, con il Nord che cerca di affrontare l’“interdipendenza” e la relativa diffusione di ricchezza che loro stessi hanno avviato. La globalizzazione è stata così “vincente” che l’instabilità sistemica è emersa prima di quanto previsto. Con “vincente” si intende che quelle differenze di tasso di crescita relativa e le tendenze successive tra il Nord industrializzato e il Sud emergente sono diventate sufficientemente significative da produrre resistenza nel corpo politico del mondo sviluppato. I BRICS sono espressione di questa diffusione di ricchezza e potere.
Avendo acquisito l’attuale posizione, i BRICS dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel modellare l’ordine mondiale post-crisi producendo un discorso alternativo che cerchi di modificare la globalizzazione. Una delle rimostranze legittime delle élite dei BRICS è che sono state escluse, o semplicemente ignorate, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale quando sono state concepite e create la maggior parte delle istituzioni di governance contemporanee. Ora, essendo a un punto di inflessione e forse alla vigilia di un altro tumultuoso adattamento globale, i BRICS non possono esonerarsi dal formare una visione trasformativa.
Sostanzialmente, il contributo più importante dei BRICS alle relazioni internazionali dovrebbe essere non semplicemente di equilibrare il potere ma di promuovere nuove norme e relative istituzioni che colmino l’assenza di governance globale attuale. Solo quando le reti intergovernative del Sud come i BRICS raggiungeranno un livello di coesione, capacità, legittimità e credibilità per affrontare le questioni sistemiche e quindi per rappresentare un’alternativa istituzionale agli accordi dello status quo, allora le potenze emergenti saranno in grado di poter approfittare delle alternative. Per ora, i BRICS potrebbero non avere tutti questi prerequisiti.
Tuttavia questi paesi stanno già lavorando e gli analisti del Sud fanno un disservizio quando criticano il raggruppamento. La questione di cui si dovrebbe discutere, comunque, è la direzione che i BRICS dovrebbero prendere. Sarebbe veramente tragico se diventassero una piattaforma per locali che cercano potere o un simbolo di cambiamento superficiale.
(Traduzione dall’inglese di Alessandra Giammattei)